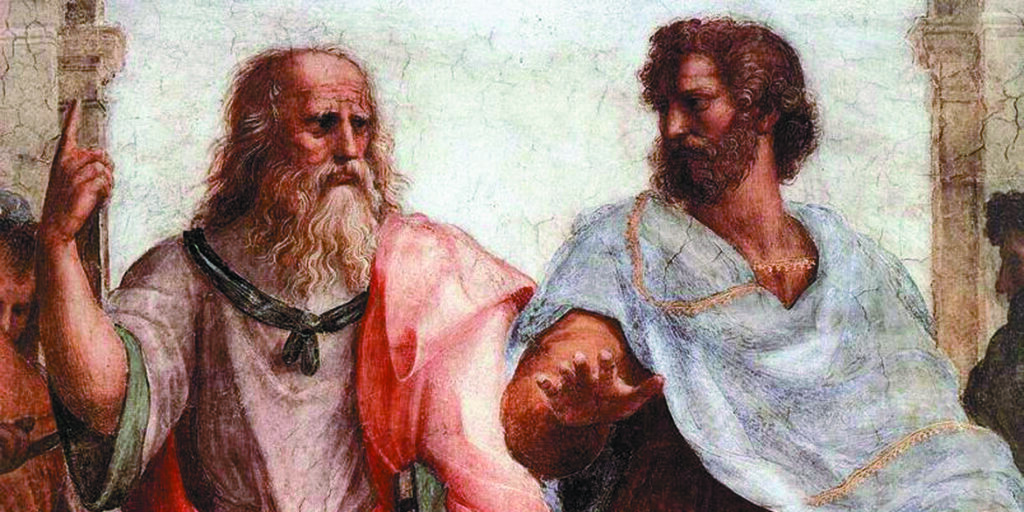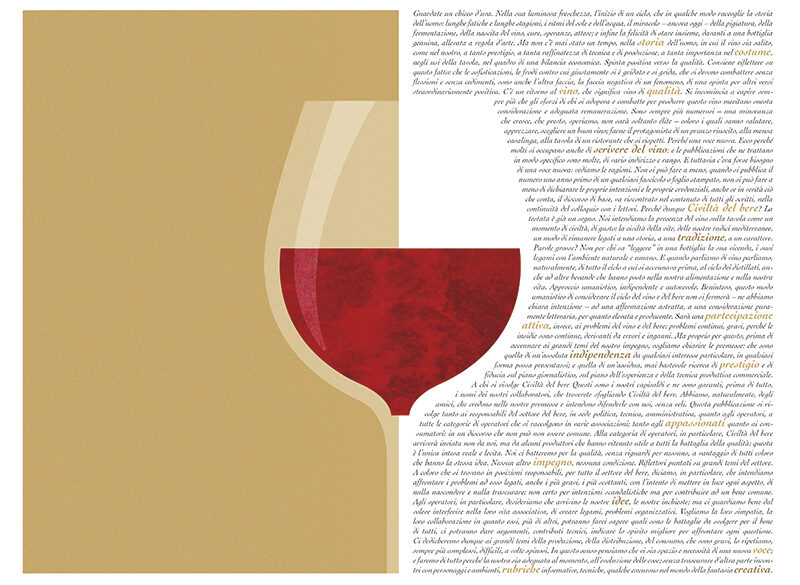Di natura o di artificio? Di cosa parla il vino?
Questa settimana affrontiamo un tema particolarmente alto: una riflessione filosofica sul tema del “naturale”, scritta da Massimo Donà (docente di Filosofia all’Università San Raffaele di Milano) tratta dalla monografia pubblicata sul numero 3/2020 di Civiltà del bere. L’argomento è ancor più attuale, considerata la recente pronuncia della Commissione Europea, che considera il termine “naturale” apposto sulle etichette misleading, ossia fuorviante.

Massimo Donà
Prodotto reso certamente possibile dalla natura (come tutto), ma sicuramente non capace di farsi da sé. Perché dall’uva possa prodursi del vino, infatti, è necessaria una complessa sapienza; chimica, biologica, enologica e geografica. Insomma, non si nasce enologi. Mentre si può nascere artisti.
Il vino viene prodotto con fatica e impegno costanti. Anche quello cosiddetto naturale – che comunque è tutto fuorché naturale. Se naturale è tutto ciò che “si fa da sé” (come ci ha insegnato Aristotele), il vino è quanto di meno naturale vi sia. Perché ha ben poco a che fare con il semplice succo d’uva.
Il vino ha un’anima
Il vino, peraltro, è anche dotato di un’anima. Lo sapeva bene Baudelaire.
Nelle parole del poeta francese, infatti, il vino appare addirittura dotato di parola. Ed è capace di parlarci; e di farsi capire. Solo il vino, cioè, avrebbe potuto rivolgersi al nostro animo inquieto con parole struggenti e consolatrici. Capaci addirittura di infondere speranza.
Eppure è anche lui – come noi – imprigionato; come noi, che tanto spesso ci sentiamo estranei e rifiutati da un mondo che non di rado appare tragicamente intrasformabile. Destinato ad essere così com’è. A resistere, cioè, ai nostri ripetuti tentativi di trasfigurazione.
Eppure, il vino sa anche venirci in soccorso.
Sa parlarci dalla sua prigione di vetro, e cantare versi pieni di luce e fraterno afflato. Il vino si annuncia luminoso e generoso; mai ingrato, cioè, verso coloro che, con tanta fatica, studio e sudore della fronte, siano riusciti a produrlo. Anche perché prova una gioia sconfinata a scivolare lungo la gola dell’uomo affaticato e stremato dal lavoro richiesto per la sua produzione.
Luce da luce, che riesce ad aprirsi un varco e a ferire la nebbia che da sempre avvolge le nostre vite; donandoci ogni volta nuova energia. E consentendo alla nostra finitezza di inscriversi in un virtuoso e liberatore moto senza fine; anche perché mai l’infinità cui da sempre aneliamo potrebbe darsi come acquisizione definitiva o possesso sicuro.
Ma ascoltiamo le parole del vino:
Uomo, caro diseredato, eccoti un canto pieno di luce e di fraternità da questa prigione di vetro, da sotto le vermiglie ceralacche!
… sento una gioia immensa quando scendo giù per la gola d’un uomo affranto di fatica, e il suo caldo petto è una dolce tomba dove sto meglio che nelle mie fredde cantine.
Senti come echeggiano i ritornelli delle domeniche? Senti come bisbiglia la speranza nel mio seno palpitante?
Nulla è più metaforico del “naturale”
Certo, la vite allude in quanto tale alla vita.
Ma la vita è movimento, trasformazione e metamorfosi incessante. Il contrario, cioè, della fissità e inamovibilità della morte. La vita è insomma possibilità di miglioramento, di crescita; e dunque è anche fondamento della speranza. Nulla, in effetti, potremmo mai sperare in relazione al definitivo e all’immutabile; perciò il vino è anche una radicale confutazione nei confronti di ogni idea che vorrebbe la storia condannata a farsi “destino”.
Il vino è la più radicale confutazione della convinzione – invero, alquanto diffusa – secondo cui la nostra inquietudine ci spingerebbe a rompere gli equilibri del naturale, e ad instaurare comunque e dovunque una prevaricante artificialità.
Il vino è trasformazione; come ci insegna Baudelaire.
Vita, movimento, ossia il contrario della fissità cui ancora in troppi vorrebbero cristallizzare le opposte determinazioni della vita e della morte, della naturalità e dell’artificialità. D’altronde, nulla è più metamorfico del “naturale”, ci insegna Goethe.
Che è esso, anzitutto, a voler essere sempre altrimenti da come è; a costruirsi e progettarsi, facendo di ogni supposta e immota “naturalità” un semplice punto di partenza. Un dato… a partire da cui dovremo sempre sforzarci di costruire qualcosa. E fare un passo in avanti. Per costruire un vero e proprio artefatto. Ossia, qualcosa di prodotto, e non “dato”.
Qualcosa in cui il dato possa riconoscere piuttosto la propria originaria vocazione; come se si trattasse della sua unica possibile meta. La meta di un’esistenza inquieta alla ricerca di qualcosa che dovremo sempre ancora diventare. Qualcosa che, comunque, finiremo per cercare e volere anche a prescindere dalla sua utilità specifica. Ossia, a prescindere dal fatto che renda possibile il nostro sostentamento.
Il dominio dell’idea
Sì, perché il vino è certo un alimento, ma non è il solo.
Di molte altre cose infatti ci alimentiamo. E non potremmo farne a meno. Perché l’essere umano non vivrebbe se non mangiasse.
Ma il fatto è che si può mangiare in molti modi.
Il cibarsi, infatti, ha la stessa caratteristica che Aristotele attribuiva all’essere. Proprio come l’essere, insomma, il cibarsi si dice in molti modi.
Alcuni esempi. Si può mangiare per pura esigenza fisiologica. Si può mangiare per soddisfare un dettato divino. Ma si può mangiare anche per provare piacere. E poi si può mangiare con le mani oppure con le posate. Si può mangiare passivamente, ingerendo quel che capita, oppure si possono scegliere le pietanze. E lo si può fare per un’infinità di motivi – per assecondare una tradizione di cui ci si dovesse sentire eredi, per corrispondere alle più diverse costellazioni valoriali.
Ma soprattutto due sono i modi fondamentali con cui ci si può rapportare al cibo.
Il primo: quello meccanico, corrispondente al bisogno di appropriarsi del mondo esterno, ingerirlo e assimilarlo, e infine digerirlo, secondo schemi e pratiche consolidate.
Dove, a dominare è sempre e comunque una prospettiva universalistica, ancorata al dettato di ricettari destinati ad imporre supina fedeltà. Dove si eseguirà perché ci si fida del parere degli esperti; e al massimo si potrà sperare in una accettabile conformità al metodo (imposto per garantire un risultato gradevole e sano).
Dove, a decidere il gioco sarà comunque la “regola” (funzionante come una sorta di idea platonica); valida per tutti, indipendentemente dall’irripetibile unicità di chi vorrà attenervisi.
Statica e tendente a fare, del risultato, qualcosa di comunque prevedibile. Qualcosa di corrispondente alla “naturale” vocazione del cibo medesimo. E dunque destinato a rendere possibile il nostro sostentamento. A non costruire nulla di diverso da quello di cui la nostra “natura” ci rende bisognosi.
E poi il secondo: dove, a mettersi in gioco, sarà invece l’irripetibile singolarità che tutti ci riguarda.
Ecco, qui il dominio dell’idea viene messo radicalmente in questione.
D’altronde, la singolarità nega, per definizione, ogni forma di identificazione omologante. Ecco perché solo in questa prospettiva potremo veramente “sperare”; con buona pace di Spinoza e di Nietzsche, che aborrivano un tale sentimento. Solo in questa prospettiva ci si può fare portatori di sane ed entusiasmanti utopie.
Unicità e artificio
Solo da questo punto di vista ci si dispone all’invenzione, all’inaspettato e all’imprevisto, e si riescono a liberare i moti della fantasia. Mettendocisi davvero in gioco, consapevoli che il cibo potrà sempre riflettere e restituire quel che di noi mai sarà realmente condivisibile: e che purtuttavia più di ogni altra cosa, forse, ameremmo condividere. Ossia, la nostra ingiustificabile “unicità”.
L’artificio che potremo sempre ancora produrre; di là da quel che ci troviamo ogni volta ad essere.
Corrispondente alla sana artificialità del vino; che era uva, ma poi si lascia lavorare, trasformare ed elaborare… sempre in corrispondenza a quel che potevamo esserci proposti di realizzare – comunque e in ogni caso a partire dalla consapevolezza relativa al fatto che mai esso sarebbe potuto diventare quel che potremmo anche esserci proposti di produrre, in virtù di una progettazione necessariamente artificiale. Ossia, naturalmente artificiale. Ché è proprio la “natura” ad averci resi capaci di artifici sempre più elaborati e lontani dal contesto in cui potremmo esserci ritrovati originariamente a vivere.
L’origine e il monito
Da cui l’azzardo e il prospettarsi di una nuance analoga a quella che sinora ci siamo limitati a riconoscere alle grandi opere d’arte.
Protese, quasi sempre – come i grandi vini, peraltro –, a custodire quella natura che il bisogno e la volontà di trasformare la datità sono sì destinati a travolgere, corrompere e trasfigurare. Ma anche a custodire come l’ombra da sempre prodotta dalla luce diffusa dagli umani artefatti, quale memoria della loro stessa ineludibile “origine”. Un’origine ineludibile ma insieme intraducibile, oscura, enigmatica e buia; illeggibile e incomprensibile, ma purtuttavia sempre anche fungente da monito che un limite andrà comunque rispettato… che un ethos dovrebbe comunque guidare le nostre sempre possibili urgenze creative, e che finanche la più raffinata artificialità – di fatto familiare a tutti i veri produttori di vino – dovrebbe non dimenticare di essere essa medesima ineludibile espressione di quella naturalità che essa stessa finisce per mettere in discussione ogni volta che si prodiga per corrispondere ad una sua “chiamata”.
Sì, perché una cosa è certa: il vino è simbolo di quella intrascendibile metamorficità che impedisce di dire cosa esso sia.
Di dirci qualcosa di diverso dal suo poter essere sempre diverso da sé. Portatore di verità e produttore di menzogna; apportatore di sollievo, ma insieme alimento e condizione di possibilità delle più diverse forme di inquietudine. Fonte di beatitudine, ma sempre anche di disperazione.
D’altro canto, il passaggio da uno stato a quello opposto è quasi sempre reso possibile dal vino, che proprio di tali interstizi si nutre, nutrendo il nostro perenne bisogno di modificarci, sorprenderci e sorprendere; e dunque di rinnovarci, ossia, di ricominciare da capo. Perciò tutto ebbe inizio dal vino… dal ritorno di Dioniso dentro le mura di Tebe e dall’ubriacatura di Noè. Da ritualità oscene che la storia si sarebbe fatta carico di “coprire”, come Sem e Jafet avrebbero fatto con Noè e Dioniso con la propria insostenibile natura divina.
Immagine in apertura: Platone e Aristotele (Raffaello, Scuola di Atene)
La Terza Pagina è dedicata alla cultura del vino e ospita opinioni su temi di ampio respiro. Dopo aver letto che cosa ne pensano gli esperti coinvolti, puoi contribuire ad alimentare il dibattito scrivendoci qui.
Per restare aggiornato iscriviti alla newsletter.