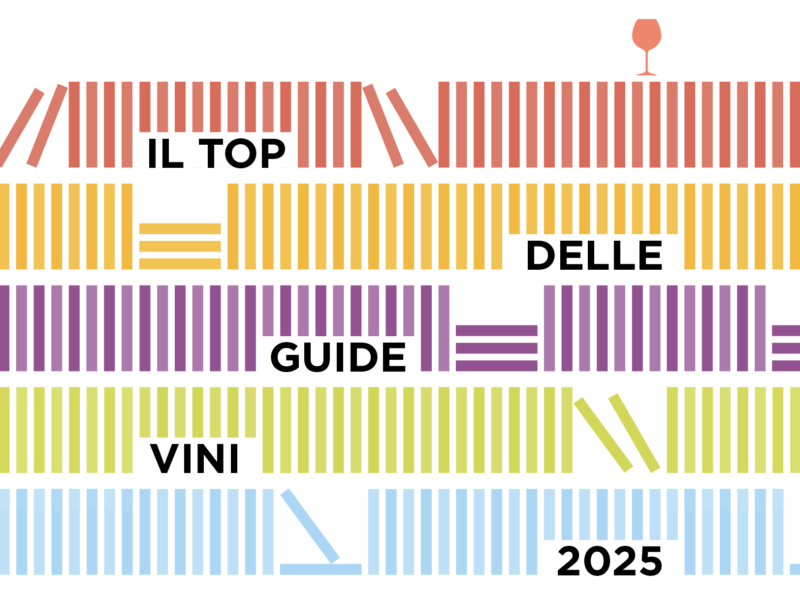Il viaggio alla scoperta della produzione eroica valtellinese (dopo le tappe a Maroggia, Sassella, Grumello e Inferno) ci conduce nella sottozona più ampia e ricca di corsi d’acqua, ma anche di incisioni rupestri preistoriche. La visione appassionata e competente di Danilo Drocco (della Cantina Nino Negri) e Marco Fay (dell’azienda Sandro Fay).
Per lungo tempo si è ritenuto che Valgella – la sottozona più ampia del Valtellina Superiore, 137 ettari tra i 350 e i 650 metri di altitudine – significasse “piccola valle”; mentre è chiamata così per i numerosi corsi d’acqua (valgèl) che scendono dalle vigne. L’epicentro dell’area è Teglio, la patria del pizzocchero che dall’alto dei suoi 850 metri di quota domina la parte mediana della Valtellina, la quale deve il proprio nome proprio a questo comune (Vallis Tellina, valle di Teglio). Sulla cima del suo sperone roccioso si staglia la torre medievale “de li belli miri”, visibile anche dal fondovalle. Se le rocce della Valtellina sono puntellate da incisioni rupestri, la Valgella è a riguardo una sorta di “montagna sacra” per l’importanza di alcuni ritrovamenti, primi tra tutti le tre stele preistoriche rinvenute a Caven.
Uno storico e celebre casato
Il nome della Nino Negri rappresenta da più di un secolo la tradizione del vino valtellinese. La Cantina fu fondata nel 1897 dall’omonimo capostipite, nato nell’Aprica da una famiglia di albergatori e commerciante all’ingrosso di vino in Svizzera. Il quartier generale dell’azienda, situato nel borgo di Chiuro, mostra ancora le proprie vestigia storiche nella corte d’ingresso e negli spazi del castello rinascimentale in pietra, che ospita le labirintiche cantine in cui trovano dimora poco meno di 1.000 barrique e 265 botti.
La più piccola ha un volume di 750 litri, la più grande di 210 ettolitri, la più giovane è del 2014 mentre la più vecchia ha 105 anni. La Nino Negri, oggi sotto l’egida del Gruppo Italiano Vini, è guidata dal piemontese Danilo Drocco, classe 1965, che in precedenza era alla direzione di Fontanafredda; dal 2018 ha preso il posto di Casimiro Maule, l’enologo storico della casa, che la guidava dal 1986.
Il lato fresco e minerale del Nebbiolo
«Qui non c’è la complessità aromatica o la potenza del Nebbiolo di Langa, ma la freschezza, il lato minerale. Non c’è nemmeno la terra del Piemonte, perché qui è tutta roccia e le radici non vanno in profondità» spiega Danilo Drocco. «Anche il clima è diverso: le escursioni termiche esaltano il lato fresco e salato della Chiavennasca. Il vino va svinato e messo nel legno presto, senza travasi all’aria. Preferisco fare delle macerazioni con l’uva diraspata e non pigiata che permette di ottenere dei profumi eleganti. Tolgo il raspo perché quello della Chiavennasca è erbaceo. Le macerazioni sono piuttosto brevi, una decina di giorni. La carica tannica della chiavennasca è inferiore a quella del Nebbiolo di Langa, ma la buccia è più spessa e se la spacchi si liberano delle sensazioni amare: va dunque trattata con rispetto».
Le quattro “s”: sudore, sterco, sole, sasso
Il maestoso Fracia è uno dei più celebri vigneti della Valgella: il toponimo è attestato dal 1600, insieme agli appezzamenti. A causa dei terrazzamenti molto ripidi la lavorazione delle vigne è talmente faticosa che per avere una buona vendemmia, si dice in zona, «servono le quattro “s”: sudore, sterco, sole, sasso». Tradizionalmente (oggi non più) il Fracia veniva considerato una sottozona al pari del Grumello o dell’Inferno.
Il cru della Nino Negri si estende per otto ettari compresi tra i 375 e i 600 metri di quota, con impianti per la maggior parte a girapoggio e la rimanenza a rittochino. Nel suolo c’è lo scisto nero di Edolo. Il microclima è così caldo che l’agave e il rosmarino crescono in pieno inverno. Il Valtellina Superiore Valgella Vigneto Fracia trascorre, come gli altri due celebri cru della casa (il Grumello Sassorosso e l’Inferno Ca’ Guicciardi), un anno di maturazione in botti di rovere di capacità variabile dai 20 agli 80 ettolitri e un altro anno di affinamento in bottiglia. Ha colore granato classico, un olfatto intriso di elementi minerali, canfora, spezie e fiori, una bocca piena, di gusto montano, attraversata da desinenze balsamiche, scandita da un tannino rigoroso e da un finale di fiori e viole.
Marco Fay e la divisione qualitativo-altimetrica
La prima cosa che fa Marco Fay quando vai a trovarlo è portarti alla chiesa di San Bartolomeo a Teglio, punto panoramico perfetto per vedere la linea insubrica e distinguere le tre fasce qualitative della Valtellina, che Marco diversifica per altimetrie. «La parte più bassa del fondovalle, a circa 300-350 metri di altitudine, è la più fredda e umida dal punto di vista climatico, fatto che provoca un ritardo di maturazione delle uve. Le bucce più fini danno vini freschi, chiari e meno tannici, da cui nascono le linee base dell’azienda. La parte più alta, che supera i 650 metri, ha un germogliamento tardivo, le uve si difendono meglio dall’umidità e le bucce sono più grosse: è dunque vocata all’appassimento dello Sforzato. La fascia intermedia, che dai 450 arriva ai 600-650 metri, è invece più soleggiata, ha maggiori escursioni termiche durante la vendemmia e favorisce una maturità ideale».
Le virtù del girapoggio
Tellino, classe 1978, Marco entra nel 2002 nell’azienda fondata trent’anni prima dal padre Sandro Fay, il quale, a partire dagli anni Ottanta, è stato uno dei protagonisti della Valtellina e della Valgella, con un pionieristico lavoro di riqualificazione del territorio e di valorizzazione dei singoli cru. Marco ha rivoluzionato la gestione del vigneto di famiglia, invertendo gli orientamenti da rittochino a girapoggio, che secondo lui garantiscono una maturazione migliore. «Il rittochino sfrutta più razionalmente lo spazio da muro e muro, e fa più produzione con il doppio o triplo archetto. Si lavora sempre a piedi pari e durante i trattamenti fai due filari alla volta per la parete fogliare bassa. Ha però il limite di non sfruttare appieno l’esposizione del mezzogiorno, la parte più calda a livello termico della giornata, pienamente assorbita invece dal girapoggio».
Dal 2013 la Riserva Carterìa
Proveniente da uno dei cru più importanti del territorio (il toponimo è conosciuto come Cartaria dal 1543 ma è citato come Artaria già nel 1473), il Valtellina Superiore Valgella Riserva Carterìa è il vino storico della casa. Lo faceva il nonno, mentre il padre produceva la Riserva, le due cose si sono unite dall’annata 2013. Il vigneto si estende per quattro ettari, tutti a girapoggio, a 500 metri di quota: accorparlo è stata un’impresa.
«Mio padre ha ultimato l’opera nel 1997 e ha sempre detto di aver speso più di atti notarili che di terra». Il vino matura per un anno in botte di rovere austriaco da 30 ettolitri e in tonneau da 500 litri, con un affinamento di un anno e mezzo in bottiglia. Ha un colore intenso, profumi esotico-speziati, un palato succoso, tenace, fresco-balsamico, che con il tempo aumenta la sua cassa di risonanza verso il pino silvestre, le erbe officinali, l’eucalipto.
Foto di apertura: © elaborazione grafica di V. Fovi
Per scoprire gli altri vini di montagna clicca qui+