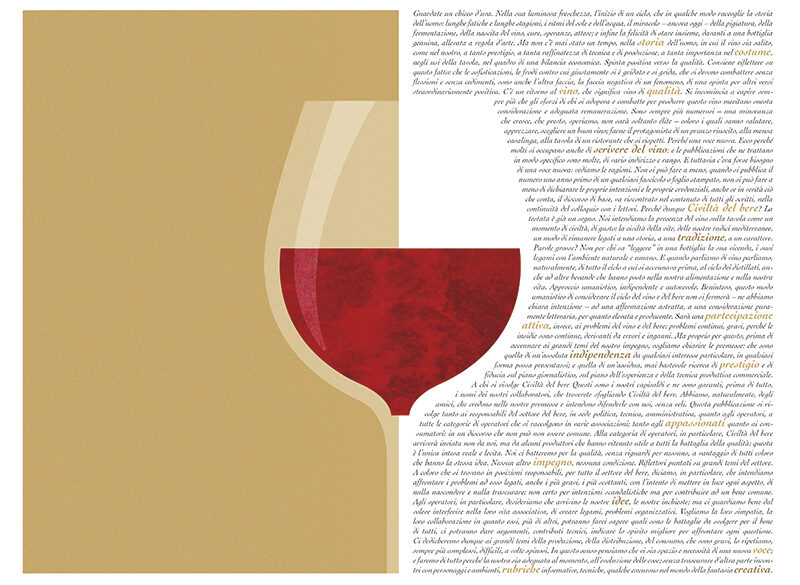Il mito della Francia
E così nacquero i nostri miti, che guarda caso sono spesso de finiti (e a voi, lettori esperti, il divertimento di capire a quali etichette ci riferiamo) “il Pauillac di Bolgheri”, “il Romanée-Conti di Sicilia”, “il Montrachet delle Langhe”, “il Pétrus del Lazio”, “lo Champagne di Trento”. Tutti vini mostruosamente buoni, ça va sans dire. E dietro alla vibrante e in fluente prosa di Veronelli, un’elegante signora francese si premurava, suscitando qualche sarcasmo, di venderle, queste barrique miracolose.Gli anni della purezza
Non stupisce, quindi, che gli anni Duemila furono quelli del rigetto reazionario, d’ispirazione vagamente nazional-socialista, ovvero gli anni “della purezza”. Si cominciava anche a notare che non tutti nel mondo si lasciavano stregare dall’allure francofona. Anzi, per colpire al cuore l’ormai distratto consumatore, diventava necessario equipaggiarsi con armi più moderne ed e fficaci, con un marketing da guerra, vitigni riconoscibili e una certa potenza d’urto: la California poteva insegnare qualcosa. Così, Chardonnay e Cabernet all’americana, Sauvignon alla neozelandese, Syrah all’australiana, che cominciavamo a defi nire “internazionali” più che francesi, sbaragliavano sui mercati del mondo.Autoctono è bello
Irruppero sulla scena i vini varietali, e ai sacri convivi (gli odierni wine-tasting) stuoli di novizi sommelier salmodiavano un noioso ritornello agli astanti, attoniti produttori: “è in purezza?”, “solo Sangiovese?”, “Chardonnay cento per cento”? Nella retorica della purezza si è dunque facilmente inserito un aggettivo dal sapore nazionalista che, per conto suo, stava già intrigando alcuni bevitori stanchi dell’omologazione bordolese: gli anni Duemila sono quelli “dell’autoctono”, della riscoperta di vitigni rari, antichi, locali. Passerina, Pugnitello, Pecorello, Pecorino d’improvviso meritano più attenzione e rispetto del povero, prima osannato e poi deprecato, Merlot.Gusto minimal. L'assoluto annoia
Non è forse un caso che, proprio sull’onda lunga della purezza autoctona, scoppia lo scandalo Brunello che, nel decennio precedente, per compiacere i palati internazionali era stato imbastardito con i geni francesi, mentre i Supertuscan, resi “super” proprio da questo nobile matrimonio di respiro europeo (Sangiovese con Cabernet e/o Merlot), cominciavano a dover rimpicciolire sulle schede tecniche i caratteri tipografi ci con cui erano scritti i vitigni. Meglio evitare imbarazzanti domande sulla purezza della razza. Ed eccoci al presente, agli anni Dieci del Duemila. Stanchi dell’assoluto, che inizialmente inebria ma in ne annoia, disillusi di fronte al mito americano o francese, stiamo entrando del decennio minimalista o “del senza”.Nuovo modello la Borgogna
Ispirati dal motto jobsiano less is more, oggi amiamo comunicare per sottrazione. Sulla tavola è tutto senza zucchero, senza glutine, senza grassi, senza uova. I vini sono prodotti senza diserbanti in vigna, fermentati senza sol ti, sboccati senza dosaggio… e ovviamente, a nati senza barrique. E i rossi sono anche senza colore, se possibile, perché oggi si cerca l’eleganza anoressica, dopo decenni di vini ciccioni. Il paradigma dominante si è spostato da Bordeaux alla Borgogna.I tormentoni del vino italiano. Basta imitare!
Si torna al punto di partenza: un grande Barolo evoca Chambertin. E si apre il capitolo del prossimo decennio, quando saremo tanto consapevoli del nostro valore, dell’unicità delle nostre denominazioni, delle nostre tenute agricole, da abbandonare defi nitivamente la corsa all’imitazione. Senza curarci troppo dei tormentoni, della barrique, della purezza, dell’autoctono, dei sol fiti. Senza paura. Gli anni Venti del Duemila potrebbero essere senza complessi o “dell’autenticità”.Questo articolo è tratto da Civiltà del bere 05/2016. Per continuare a leggere acquista il numero nel nostro store (anche in edizione digitale) o scrivi a store@civiltadelbere.com. Buona lettura!