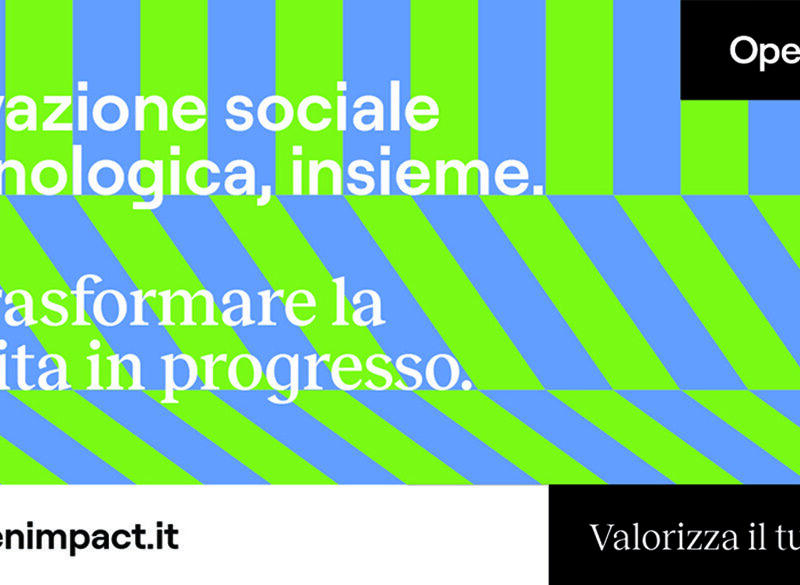Per Sata lavorare a basso impatto ambientale significa esplorare la biodiversità e comprenderne il funzionamento. Così conducono le indagini i professionisti dello studio agronomico, misurando la Qualità biologica del suolo.
Li chiamano indicatori vivi. Sono una passione, ma soprattutto rappresentano la scienza. «Ci basiamo su indicatori», spiega Pierluigi Donna, «orientati a migliorare il processo d’indagine. Quando un indicatore è un organismo vivente, genera interesse da parte di tutti». Sata è una società fondata da un gruppo di consulenti che si è specializzata nell’analisi e nella comprensione scientifica del suolo e delle sue correlazioni con l’uva e il vino.
L’importanza di un’informazione oggettiva
«Ho mandato a un’azienda siciliana il report di 50 pagine colmo di numeri», spiega ancora Pierluigi Donna. «Il vantaggio è l’oggettività della informazione. L’azienda diffonde il documento a tutto lo staff. Incontro il direttore commerciale e mi evidenzia quanto è stato colpito dal report e quanto abbia compreso gli aspetti più pregnanti dell’osservazione. A noi serve da un punto di vista tecnico, non solo etico. Per lavorare a basso impatto ci vogliono alleanze con la natura. E la biodiversità è uno di questi alleati».
Come ci sia allea con la natura
Per ottenere questa alleanza con la natura è necessario esplorare la biodiversità di un suolo, ma oltre a descriverne la composizione, capirne il funzionamento. Vediamo qualche esempio. L’indagine nei confronti della sostanza organica è portante. L’immobilizzazione di CO2 e la disponibilità per la pianta sono cruciali. Nella viticoltura di collina la difformità di vegetazione è costante. Si va quindi a fertilizzare nelle zone più magre del terreno.
La Qualità biologica del suolo
«Le aree più magre», dice Stefano Saderi riferendosi a un esempio specifico, «erano quelle con più dotazione di sostanza organica. Perché?».
Qui si entra nel cuore dell’attività di Sata e delle discipline che culminano nell’analisi dei microartropodi per indicare la Qualità biologica del suolo (Qbs). «Tramite questa analisi», continua Saderi, «in quelle postazioni la sostanza organica, che è il letto che accoglie gli organismi, non li supportava a sufficienza. Ricostruiamo la storia di quel versante e vediamo che la sostanza organica non era compostata e non sfruttava i minerali. Era un errore aggiungerne altra come si sarebbe fatto in una tradizionale gestione del terreno. Era invece necessario arieggiare e mineralizzare quella che già c’era. Così gli organismi sarebbero ritornati a pullulare».
Quali sono le relazioni con la qualità del vino?
Il lavoro di Sata si spinge fino a correlazioni con la qualità del vino. Non senza prudenza. Basandosi su fondamenti scientifici, «la correlazione statistica è più difficile perché il concetto di qualità è difficilmente oggettivizzabile» aggiune Saderi. «Il punteggio Qbs (in base ai microartropodi) è spesso correlato alle riserve delle aziende, cioè ai migliori vini. A Qbs alti corrisponde una storicità aziendale, ma anche livelli di rame più alti. Le vigne storiche possono mostrare livelli di rame di poco superiori all’usuale, a causa delle antiche tecniche di difesa, seppur con indici di biodiversità eccellenti. Oggi la gestione di questo elemento è molto cautelativa».
Foto di apertura: Paolo Di Francesco, Pierluigi Donna, Marco Tonni, Stefano Saderi e Angelo Divittini