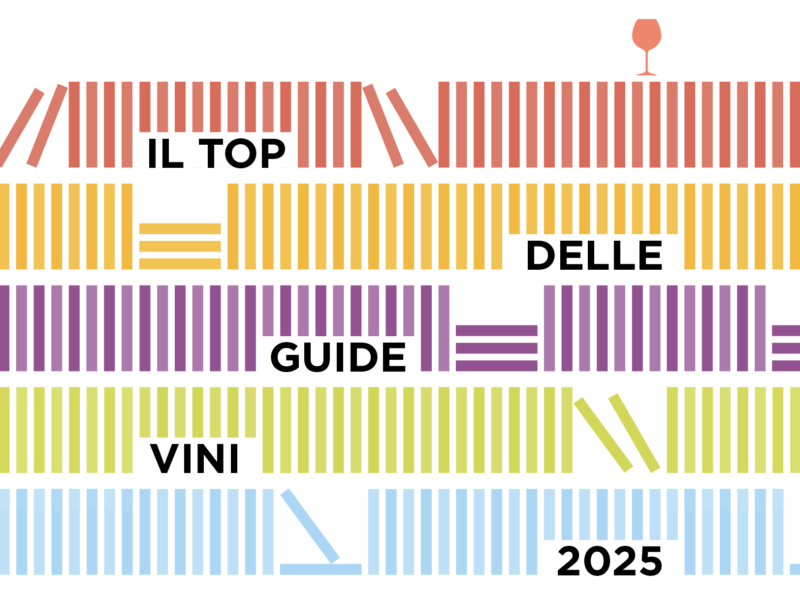di Stefano Tesi
Si chiamavano anglobeceri quei copiosi inglesi che, stanziatisi a Firenze tra l’Ottocento e il Novecento, pur mantenendo i tratti britannici si erano presto impadroniti dell’espressività locale, gesticolazione inclusa, e avevano imparato a farne ampio uso, dando luogo a curiosi ibridi comportamentali.L'anglobecero dei giorni nostri
Il termine anglobecero – parola che va usata con prudenza per non risultare troppo screanzati – si è esteso poi a indicare certe correnti e ricorrenti espressioni toscane, non precisamente signorili, che gli anglobeceri si erano col tempo abituati a usare, contribuendo così a incrinare il loro aplomb. Nel corso dell’ultimo mezzo secolo, complice l’invasione yankee e le esigenze di rimorchio, i ruoli si sono però capovolti: sono stati gli italiani a farsi contaminare dall’eloquio dell’anglobecero, arricchendolo con i termini più maccheronici e così regalando, involontariamente, locuzioni indimenticabili anche ai creativi della pubblicità (chi non si ricorda il “du gust is megl che one” degli anni Novanta?).La giungla lessicale del web
Poi sono arrivati i computer, quindi internet e infine gli smartphone. E allora si salvi chi può. Per gli over 40 è stato come trasferirsi in Australia da un giorno all’altro. Per gli under, quasi. Una giungla lessicale da assimilare alla svelta, acriticamente, tanto per cavare le gambe dall’informatica quotidiana e senza avere la più pallida idea del reale significato delle parole. Fin dal Duemila, per dirne una, molti conoscono il termine bug, ma pochissimi sono capaci di tradurlo nel corrispondente italiano di virus o batterio. Se lo facessero, non si sentirebbero forse abbastanza anglobeceri?Lo slang del vino on line
Il mondo del vino ovviamente non è immune da questa sindrome e anzi ci va pericolosamente sprofondando dentro. Basta navigare un po’ in rete. I casi si sprecano e menzionarli è fin troppo facile: app, link, password, blog, spam, web. Termini ormai entrati nell’uso quotidiano, che oggi compaiono più spesso di barrique o tonneau. Ci sono poi gli insidiosi “anglobecerismi” professionali, quelli che definirei di secondo livello: influencer, social media manager, digital pr. Poffarbacco, avrebbe detto il professor Occultis, quello del Grande Blek. Attorno ad essi aleggia tuttora una nebbiolina di vaghezza che quasi tutti avvertono, ma nessuno lo confesserebbe neppure sotto tortura. Sono il corrispondente web di certe formule enochimiche, come il TCA (la molecola 2,4,6-tricloroanisolo responsabile del sentore di tappo nel vino, ndr).Tra TCA e SEO...
All’empireo però si giunge avventurandosi nel ristretto linguaggio iniziatico usato da chi, certe funzioni o qualifiche, non le evoca, bensì le riveste: una tempesta di locuzioni davvero incomprensibili, destinate a turbinare in eterno nella confusa testa del vignaiolo comune. La più usata è senza dubbio SEO, ovvero “search engine optimization”. Tradotto in italiota terra-terra si potrebbe dire “trucchetti acchiappaclic”. Usando un linguaggio più paludato, “strumenti per ottimizzare il galleggiamento sui motori di ricerca”. A chi è d’antan, l’acronimo invece potrebbe richiamare una vecchia barzelletta: “Sei Per…seo?”, chiede l’oplita morente scambiando un soccorritore per l’amico del cuore. Ma quello, impassibile, gli risponde: “Trentaseo!”.Siti vinosi e vignaioli spiritosi
Il bello è che i SEO, nati per essere usati dalla gente intelligente, in realtà sono stupidi. Non riconoscono infatti i giochi di parole e quindi, se qualcuno su un blog o un sito vinoso mette un calembour spiritoso (tipo Perseo-trentaseo), rischia di precipitare all’ultimo posto nei “ripescaggi” di Google. I vignaioli in vena di freddure on line sono avvertiti.Questo articolo è tratto da Civiltà del bere 03/2016. Per continuare a leggere acquista l’ultimo numero nel nostro store (anche in edizione digitale) o scrivi a store@civiltadelbere.com. Buona lettura!