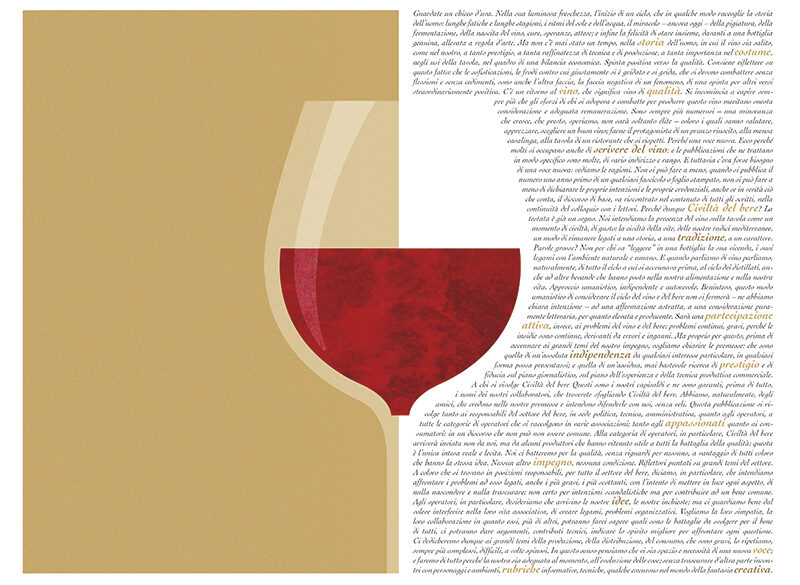Riflessioni culturali sulle bollicine simbolo del made in Italy nel mondo. Dal vignaiolo trevigiano di Germi, che il vino più che farlo lo beve, alle dolci colline di Conegliano e Valdobbiadene descritte da Piovene e dipinte dal Bellini.I veneti? Sono quel popolo per cui “il lavoro non è nemmeno un dovere, è il senso stesso del vivere”, ha scritto Stefano Lorenzetto in Cuor di veneto. Anatomia di un popolo che fu nazione (Marsilio, 2010). Lorenzetto è astemio ma ammira un suo conterraneo vignaiolo, il veronese Giancarlo Aneri, uno di quel mondo di intraprendenti, scaltri e bonari imprenditori, stakanovisti al ritmo del dialetto. Aneri, a 11 anni, “acquistava per 15 lire i cioccolatini Ferrero e li tagliava in quattro porzioni che piazzava ai suoi amichetti, guadagnandoci 25 lire”. Uno così non poteva che diventare produttore di Prosecco.
Così si alimentano vecchi pregiudizi
I veneti come lui hanno alimentato vecchi pregiudizi. Descritti come carabinieri un po’ ritardati e servette incapaci di imparare l’italiano nelle commedie degli anni Sessanta. Logico che quando è arrivato il successo, i capannoni, le bottiglie a milioni e gli schèi, siano partite anche le frecciate. Come ha scritto Ferdinando Camon, i veneti sono sempre stati malvisti, prima perché poveri, poi perché riccastri e protoleghisti. La narrazione del Prosecco, nella letteratura e al cinema, segue fedele questo schema.Prosecco: una storia veneta
La storia del Prosecco è venetissima, trevigiana innanzitutto. A Treviso arriva nel 1965 il regista Pietro Germi per Signore & signori. Il set è in piazza dei Signori. E si sposta a Conegliano, all’Osteria alla Stella. Fino a Jesolo, nello storico dancing Le Capannine. Il Prosecco allora era un vino locale. Veniva servito in caraffa nei ristoranti del lungomare. Quando Germi sbarca nel Veneto è famoso: ha firmato già tre capolavori, il neorealistico Il ferroviere, Un maledetto imbroglio tratto dal libro Quer pasticciaccio brutto de via Merulana di Carlo Emilio Gadda, e la commedia Divorzio all’italiana con Marcello Mastroianni e Stefania Sandrelli.Signore & signori, va in scena l'ipocrisia
A Treviso Germi porta la sceneggiatura di un autoctono, Luciano Vincenzoni, che ha raccolto in città storie e pettegolezzi da “vizi privati e pubbliche virtù” che svelano l’ipocrisia provinciale del Veneto negli anni del boom. Da una parte i signori di città, gaudenti che cercano di mostrarsi perbenisti, dall’altra i contadini, in bilico tra la campagna da coltivare e la fuga nelle fabbriche dei tanti centri industriali che stanno nascendo. Uno di questi contadini appare nel film. È Bepi Cristofoletto.Beota e senza morale. Il vignaiolo trevigiano negli anni Sessanta
Bepi concede alla figlia appena sedicenne di passare un pomeriggio a girare per i negozi di Treviso. Un gruppo di “signori” ne approfitta, abusando della sua ingenuità. Bepi li denuncia. I potenti preti locali convincono i giornali a non pubblicare una riga. Ippolita, moglie di uno degli accusati, va in cantina per convincere Bepi a ritirare la denuncia. Come tutti i coltivatori della Marca trevigiana, anche lui sarà stato un produttore di Prosecco. Ma senza lo status di cui possono fregiarsi ora i vignaioli. “Quelli come lui li conosco, contadini e imbriagoni”, ubriaconi, dice Ippolita, raccogliendo denaro con una colletta tra gli uomini che rischiano il processo. Bepi rinuncia alla giustizia. Ippolita gli si concede, così trattiene una parte della somma raccolta. Ecco come veniva rappresentato un vignaiolo trevigiano negli anni Sessanta: un beota che più che vendere vino lo beve, così senza morale da farsi pagare evitando di difendere la figlia.Oggi il Prosecco rappresenta l'Italia nel mondo
Anche nella versione teatrale di Signore & signori, portata in scena nel 2013 da Natalino Balasso, Bepi resta l’avido del film. Se per il produttore di vino nulla cambia, ha invece un nuovo ruolo il prodotto. Ora nelle scene che rievocano sul palco Le Capannine, non ci sono le bottiglie nel secchiello e persino il prete stringe in mano una flûte per il Prosecco. Mezzo secolo dopo, il vino locale è diventato uno dei simboli del made in Italy nel mondo. E anche il teatro lo consacra.L'articolo prosegue su Civiltà del bere 5/2018. Se sei un abbonato digitale, puoi leggere e scaricare la rivista effettuando il login. Altrimenti puoi abbonarti o acquistare la rivista su store.civiltadelbere.com (l'ultimo numero è anche in edicola). Per info: store@civiltadelbere.com