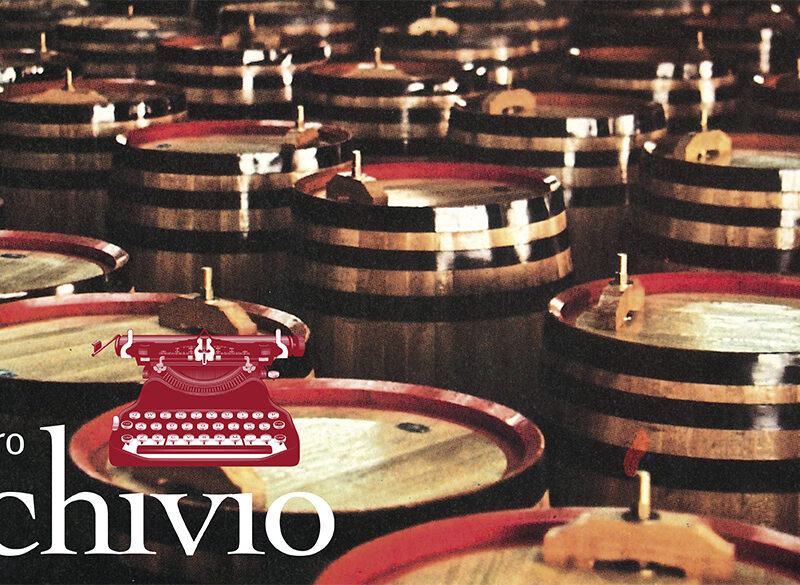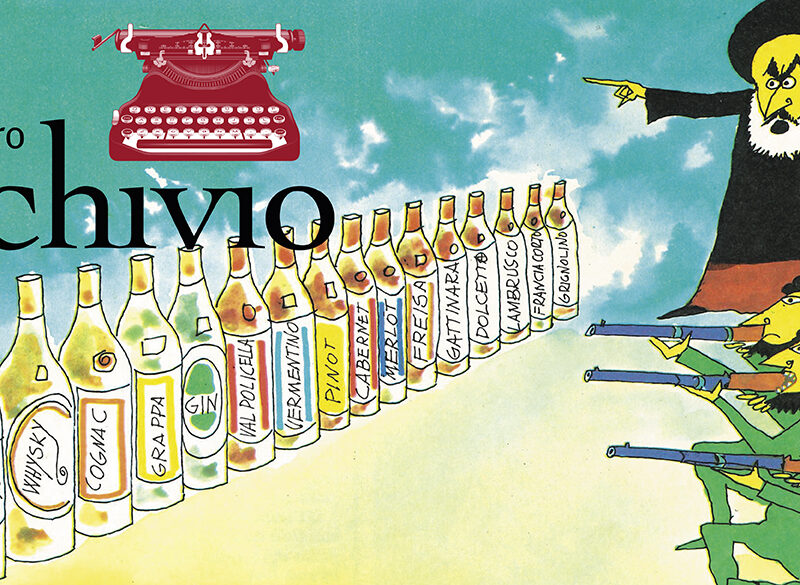In questo articolo pubblicato nel 1982 il giornalista Zeffiro Bocci racconta un episodio personale – la partenza per un viaggio di lavoro in Irpinia – a partire dalla quale inizia a ragionare sul concetto di “coscienza nazionale enologica”. Virtù decisamente più manifesta nei francesi che negli italiani
La sorpresa me l’ha fatta l’Antonia dimostrando ancora una volta d’essere lei l’unica e vera segretaria di tutta la mia, ormai non breve, “carriera”. Pochi minuti prima che salissimo la scaletta d’imbarco dell’Irpinia, avevo visto mia moglie darsi da fare, a terra, attorno al chiosco dei giornali. Ora, in nave, quando ancora dal ponte maggiore teniamo gli occhi fissi alla terra che si fa sempre più piccola, l’Antonia apre l’ampia borsa da mare e rimestando nell’arsenale di roba che ci tiene dentro, ne trae fuori un “Oscar Mondadori”: “Questo – mi dice con la consapevolezza di farmi una sorpresa – è per te”.
Una sorpresa a sfondo vinicolo
Sulla copertina del libro il Commissario Maigret, affacciato alla ringhiera di una scala, sta proteso in avanti, sul vuoto, fino al punto che mi pare che da un momento all’altro gli debba cadere di bocca la grossa pipa scura. Ma la sorpresa – sorpresa cui alludeva mia moglie – era tutta nel titolo del libro di Georges Simenon: “Maigret ed il commerciante di vini”.
Condividiamo, mia moglie ed io, il reciproco compiacimento, con una risata divertita e unisona, e poiché la mia curiosità è tanta, mi do subito alla lettura del libro.
Vin des Moines: certamente un nome, o meglio una denominazione di fantasia, una trovata pubblicitaria, come si dice, per adescare l’attenzione del pubblico e pungolarne la curiosità verso un vino la cui origine, per via dei Moines (dei Monaci), risulta un po’ un mistero…
Forse qualcosa di più: un espediente commerciale che fa leva sulla fama dei Monaci quali depositari ed esecutori di antiche “ricette” per la preparazione dei vini e, particolarmente, di liquori. Casi del genere e famosi, ci sono anche da noi, soprattutto nel campo liquoristico.
L’astuzia di Oscar Chabut
Infatti, famosissimi alcuni liquori prodotti da Monaci, le cui “formule”, a base di infusi di erbe rare, speciali ed aromatiche, da secoli rimangono nel segreto dei monasteri. Ma in fondo stando a quel che ci dice Georges Simenon, l’astuzia (un po’ truffaldina?) di Oscar Chabut, il commerciante di vini, stava soprattutto in questa trovata reclamistica; chè per quanto riguarda le miscele che venivano preparate nei suoi magazzini di Quai Charenton, tutto procedeva secondo la legge: innocenti “combinazioni” a base di ben appropriati “tagli”, nei quali i vini del Mezzogiorno di Francia costituivano la “massa” o come anche si dice la “base”.
Siamo nel romanzesco e dopotutto, qui il lecito ha margini che lambiscono l’infinito. Nella realtà, fuori dalle pagine del romanzo, le cose sarebbero state forse diverse. Probabilmente Oscar Chabut, personaggio vissuto forse più nella fantasia di Georges Simenon che nella realtà enologica parigina, non avrebbe potuto realmente “vestire” i suoi vini con l’etichetta attraente, ma fasulla, di “Vin de Moines”, senza incorrere nelle maglie della legge che vieta l’uso di denominazioni non veritiere in quanto possano comunque indurre in inganno il consumatore, circa l’origine del vino.
La brutta fine del commerciante di vini
Un fatto era certo, in ogni caso: che seppure non veniva prodotto da monaci, il vino di Oscar Chabut correva a fiumi per ogni quartiere di Parigi e anche per tutta la provincia: la catena di distribuzione contava, nientemeno, che quindicimila punti di vendita, controllati da un corpo di venti ispettori.
La posizione facoltosa cui era pervenuto, aveva immesso Chabut nel gran mondo parigino. Però più che una personalità, ne era divenuto un personaggio, ed in questo ruolo Oscar Chabut era stato favorito – pensate! – da una inesauribile vena di erotismo che gli consentiva di portarsi a letto (mi conformo al linguaggio usato dallo stesso Simenon) tutte le donne che incontrava sui suoi passi…
Finché, una sera, subito dopo il vespro, mentre la vita notturna di Parigi s’accende di desideri alle luci “maliarde” dei boulevards, un suo dipendente, tale Gilbert Pigou, già licenziato in tronco col suggello irrevocabile di uno schiaffo (elargito dal principale, per soprammercato, a sadico sfogo della sua connaturata propensione al sopruso verso i propri simili), questo Gilbert Pigou, dicevo, umiliato fino alla morte civile, avendo Oscar Chabut approfittato di sua moglie Lilane quando questa era andata a chiedergli spiegazioni sul licenziamento del marito, questo Gilbert Pigou dunque, fattosi vindice volontario anche per conto di tutti gli altri (e non erano pochi) offesi e maltrattati dallo stesso Chabut, non lo fredderà a colpi di rivoltella (lui, lo spavaldo Oscar Chabut ancora caldo dell’alcova) dinnanzi alla porta della nota casa di appuntamenti di Rue Fortuny, nel momento in cui ne usciva, dopo esserci stato a fare l’amore per l’ennesima volta, con una delle tante.
Intraprendenza, ambizione e volontà
Lungo disteso sul marciapiede, come un toro abbattuto nell’arena, la sua ombra ingombrante continua a proiettarsi per tutte le rimanenti 50 pagine del racconto, inesorabilmente, fino alla fine.
Fin qui il racconto di Georges Simenon, che io mi sono limitato a condensare all’unico scopo di trarne una “morale”, anche se la morale che intendo ricavarne non ha a che fare strettamente con i fatti narrati da Simenon.
Ciò che conta per me, è soprattutto la figura umana, la professione e lo stato civile del protagonista, che, una volta tanto, non è il Commissario Maigret, bensì Oscar Chabut. Questo autentico figlio del popolo (“suo padre, il vecchio Desiré, conduce ancora un’osteria in Quai de la Tournelle”), venuto dal niente e che pur sapendo leggere e scrivere a malapena, riesce a farsi largo in fretta raggiungendo, in virtù della sua eccezionale intraprendenza sorretta da una volontà di ferro e da una ambizione smisurata, una posizione economica e sociale di prim’ordine.
Insomma quello che solitamente si dice un uomo facoltoso, questo Oscar Chabut, che nella società alto borghese di Parigi si era fatto notare come personaggio, fino al punto di offrirsi all’ispirazione di uno scrittore, che non è certo l’ultimo arrivato, per il ruolo di protagonista di un romanzo.
Scelta curiosa per il ruolo di protagonista
Se l’Autore del libro aveva preferenza per il mondo dei business, avrebbe potuto disegnare come protagonista del romanzo un grande industriale, un grosso commerciante di pellicceria, un famoso gioielliere, un Cartier per esempio: no, la scelta immaginosa di Simenon è caduta sul commerciante di vini, semplicemente un commerciante di vini.
Da noi, per lo più, un commerciante di vino lo si chiama vinaio in segno di mal celato disprezzo e nessuno – oso pensare – nessuno scrittore italiano si sognerebbe di intrecciare una vicenda romanzesca intorno alla figura di un vinaio, anche se non mancano a casa nostra, modelli di vinai illustri, meritatamente saliti ai gradini più alti della scala sociale. Ma niente; vinaio, niente da fare.
In Italia, nonostante il gran parlare che se ne fa da alcuni lustri, il vino sotto l’aspetto umanistico appena adesso sta muovendo i primi passi nel mondo della cultura italiana. In tale direzione si stanno facendo lodevoli sforzi per fare “accettare” il vino nel giusto ruolo che gli compete nell’ambito culturale di una società civile, consapevole dell’edificazione che può venire all’uomo dal rispetto di quelle tradizioni (il vino lo esaltarono i sommi poeti dell’antichità, i grandi personaggi mitologici, ed è simbolo di vita nella liturgia cristiana), dalla cui celebrazione una nazione può ricevere una parte non trascurabile del lievito della propria crescita in termini di civiltà.
La coscienza nazionale enologica dei francesi
“Un bicchiere di vino – ha scritto Vittore Branca a proposito del Premio Civiltà Veneta – aiuta più di tante altre cose a capire l’indissolubilità del rapporto. E questo perché il vino riflette tutta una civiltà di cui esso è uno degli elementi popolari, mitologici e sacri”.
Alle corte, mi si domandi pure: “Ma Simenon si è ispirato a un personaggio realmente esistito o il personaggio di Chabut è solo parto della sua fantasia?” Ho pronta la risposta: “Non è importante che Oscar Chabut sia o no esistito; ciò che conta, invece, è che Simenon – quand’anche non si fosse ispirato a un modello reale – non ha scartato l’idea di un vinaio-personaggio-protagonista nella società di una metropoli come Parigi”.
Ed è tutto qui, perché – forse è la vera “morale” cui volevo arrivare – nella scelta di Georges Simenon molto è dipeso dalla coscienza nazionale enologica dei francesi, la quale – ci piaccia o no sentircelo dire – è assai diversa dalla nostra. Ammesso che noi italiani, oggi come oggi, ne abbiamo una.
Zeffiro Bocci