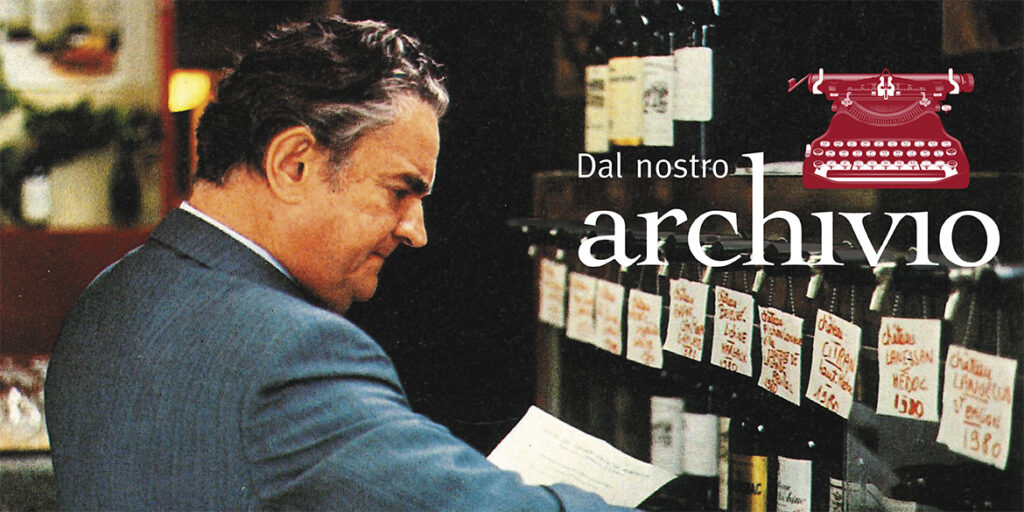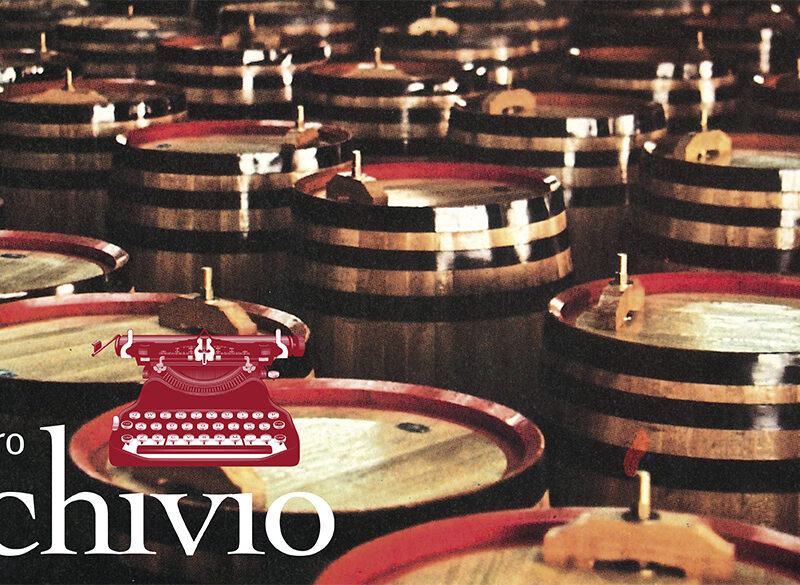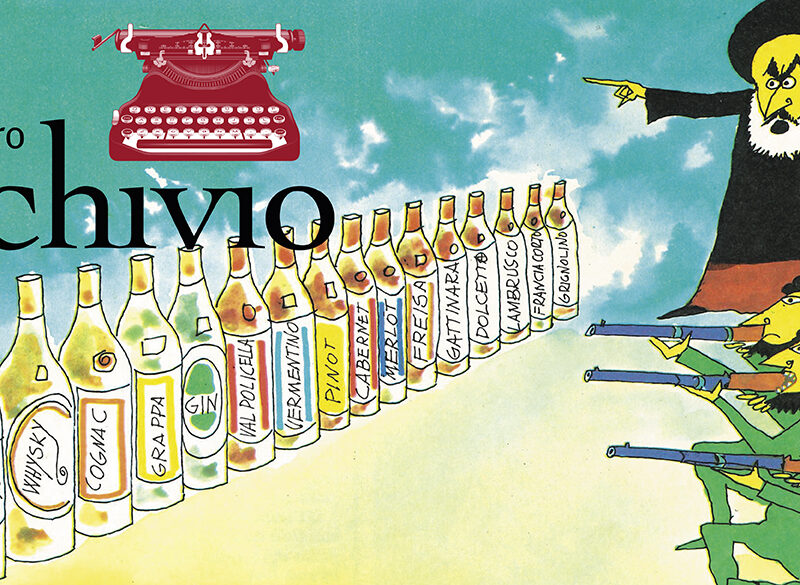In questo articolo di inizio anni Ottanta lo studioso e wine-maker francese (1912-2004), indiscusso padre dell’enologia moderna, affronta molte tematiche cruciali con grande precisione e il giusto tocco di ironia. Spiega gli errori da evitare, dà preziosi consigli ai produttori e si dichiara “abbastanza ottimista sull’avvenire della qualità del vino”.
Émile Peynaud è un enologo noto e apprezzato non meno in Italia, in California, in Africa del Sud, in Germania e in tutti i Paesi che vogliono produrre dei buoni vini e che spesso chiedono i suoi consigli, che nella sua regione natale, il Bordeaux. Laureato in enologia nel 1946, è stato il primo allievo e collaboratore di Jean Ribéreau-Gayon, considerato il fondatore dell’enologia moderna. Il 21 giugno 1977, il mondo enologico, riunito a Bordeaux in occasione del III Simposio internazionale di enologia, festeggiava il giubileo di questa fruttuosa collaborazione scientifica.
Una lunga e prestigiosa carriera
La prima parte della carriera di Émile Peynaud si è svolta prima della guerra in un’azienda privata. È a quell’epoca che furono messe a punto e perfezionate le tecniche di conservazione dei vini e di stabilizzazione delle limpidità conosciute oggi. A partire dal 1949 Peynaud ha diretto i servizi di ricerca della Stazione agronomica e enologica di Bordeaux e ha insegnato alla Scuola superiore di enologia (della quale è stato vicedirettore) e, dopo il 1968, all’Istituto di enologia.
Émile Peynaud è molto noto per le sue opere tecniche sull’enologia ed ha avuto una parte determinante nel rinnovamento delle tecniche di vinificazione e nel miglioramento della qualità dei vini prodotti con questi metodi.
Avendo terminato la sua carriera universitaria nel 1977, Emilie Peynaud si dedica oggi alla redazione di libri sull’enologia (tra i quali l’ultimo, l’imponente “Le Goût du vin. Le grand livre de la dégustation”, edito da Dunod, è di gran lunga il più importante) ed esercita un’attività di consigliere tecnico in aziende vinicole francesi e straniere.
L’accoglienza di un grande maestro
A dir la verità, ero un po’ preoccupato all’idea di incontrare Émile Peynaud che mi era stato descritto da alcuni come un personaggio di difficile accesso e da altri addirittura come una specie di cerbero. Ma, fedele, al principio che è meglio non ascoltare consigli e affidarsi piuttosto al proprio istinto, mi sono presentato una mattina piovosa d’estate al cancello della sua villetta di Talence, (alla periferia di Bordeaux), di aspetto semplice ma più che accogliente, un po’ inquieto perché leggermente in ritardo a causa di un ingorgo del traffico che aveva bloccato il mio taxi nelle vie del centro.
Come tutte le persone ben organizzate, Émile Peynaud mi aspettava già e mi ha accolto con grande cordialità, interrompendo con un semplice gesto le mie scuse. La leggenda di un Emilie Peynaud genio intrattabile era dunque sfatata e la cosa mi riempiva di piacere, innanzitutto perché è sempre sgradevole e difficile intervistare una persona con la quale non si riesca ad avere un contatto franco e aperto, poi perché, all’infuori dell’impegno professionale, avevo un vivissimo interesse personale a conoscere questo grande maestro del vino del quale avevo divorato appassionatamente quella bibbia che è “Le Goût du Vin”.
Il “mago di Bordeaux” è di casa anche in Italia
Con Émile Peynaud non è difficile entrare in argomento perché è uno di quegli uomini franchi e diretti che non hanno alcuna predilezione per le pose e, naturalmente, si è parlato subito dell’Italia e dei suoi vini. Peynaud è consigliere di alcune aziende vinicole italiane di primo piano e alcuni vini che vanno per la maggiore sono stati curati da lui. Ha tra l’altro dei contatti privilegiati con Antinori e conosce le vigne del Chianti come le sue tasche, ma le sue esperienze italiane non si limitano alla Toscana e hanno avuto, tra l’altro, come terreno anche l’Umbria, il Piemonte, la Lombardia. Insomma, possiamo dire che Émile Peynaud, che nell’ambiente dell’enologia è stato battezzato “il mago di Bordeaux”, è di casa da noi e può dunque parlare in piena cognizione di causa.
“In questi ultimi anni l’Italia ha fatto enormi progressi in campo vinicolo”, dice. “Il grave difetto del vino italiano era un’eccessiva limitazione regionale che conduceva fatalmente a inutili rivalità e a un dannoso individualismo spinto fino ad eccessi autolesionisti. Certo, l’Italia non è ancora uscita da questa regionalizzazione, ma è sulla buona strada e i suoivini si internazionalizzano sempre di più. La maggior parte dei vini italiani non erano fatti per piacere al di fuori delle regioni che li producevano, ma ora, grazie a un miglioramento sempre più rapido delle tecniche e della conoscenza, si aprono sempre più sul mondo”.
– Qual è per lei l’avvenire del vino italiano?
“In questo campo le possibilità sono immense per l’Italia, paradiso della vigna. Nel vostro Paese esistono tutti gli elementi per fare del buon vino, perciò è assolutamente imperdonabile quando se ne fanno dei cattivi. A mio avviso la situazione attuale permette un certo ottimismo, tuttavia direi che bisogna fare molta attenzione a evitare un’eccessiva industrializzazione, cercare di mantenere gelosamente la grande tradizione dei vini ed evitare una forte produttività. Per me industrializzazione e produttività ad oltranza costituiscono quello che si potrebbe definire il cancro della vigna. Per fare un discorso generale, che riguarda un po’ tutti i Paesi produttori, direi che almeno il 50% dei vini di origine controllata usurpano la denominazione, e per citare un caso che mi è familiare, direi che soltanto il 5% dei vini prodotti a Bordeaux sono eccezionali. Ma non dimentichiamo che la nostra regione costituisce il limite massimo a Nord per i vini rossi, perciò le condizioni generali non sono molto favorevoli: la prossimità dell’oceano, l’umidità e il clima eccessivamente temperato non incoraggiano certo la coltura della vigna. Esiste nella regione di Bordeaux una regolamentazione che impone che non si superino i 13°, ma per me è sufficiente limitarsi ai 12°. Il grave pericolo, anche qui da noi, è costituito dal continuo aumento del rendimento: si fa sempre più vino, grazie a tecniche sempre più perfezionate, e in 50 anni si è passati da 20-50 ql. l’ettaro a 50 ql. Ma si tratta di un circolo vizioso: un viticoltore deve fare sempre più vino, specialmente quando si tratta di bianco, per riuscire a vivere. Si tratta di un problema umano che non si deve trascurare, ma non bisogna dimenticare che più la produttività della vigna aumenta, più la qualità del vino cala”.
– Se mi permette di fare un discorso generale, cosa pensa del livello di qualità dei vini prodotti nel mondo?
“Non è molto facile rispondere: è certo che si fanno nel mondo vini eccellenti, in misura molto ridotta, naturalmente, a grandi quantità di vini pessimi. Per esempio, ho già detto in numerose occasioni e non mi stancherò mai di dire che è uno spaventoso errore storico continuare a produrre nel Midi della Francia il più cattivo “vino da tavola” del mondo, quando è possibile fare del buon vino dappertutto dove l’uva matura e dove si vinifica bene. Oggi anche i messicani e i venezuelani, per non citare che due casi che sono un po’ lontani dalla nostra vecchia Europa, ci riescono. E visto che siamo in discorso, parliamo anche della California: qui in Francia molti mi hanno rimproverato di aver detto che nella Napa Valley si fanno vini stupendi. È vero, e non posso fare altro che confermarlo, ma devo tuttavia aggiungere che se ne fanno anche di cattivi!”.
– Non pensa che il vino sia vittima non soltanto della mancanza d’informazione del grande pubblico e di un’eccessiva commercializzazione che tende a farne un “prodotto”, privandolo spesso di quelle qualità e di quell’aura così particolari che dovrebbero far parte della sua immagine, ma anche e soprattutto di uno snobismo e una speculazione che hanno assunto dimensioni enormi?
“È vero che esiste un fatto di moda e di snobismo ai vini, a diversi livelli: personalmente diffido come della peste dei bei parlatori che invece di assaggiare discutono e nascondono la loro incapacità dietro il vaniloquio. Certo, ci sono le questioni di moda, spesso dettate da imperativi commerciali, come nel caso del Beuajelais che ha fatto scuola ed è stato seguito da altri, come il Macôn o il Côte du Rhône, tanto per non citare che un paio, ma qui si tratta di fenomeni che esisteranno sempre. Tutto considerato, posso affermare di essere abbastanza ottimista sull’avvenire della qualità del vino, basandomi sulle statistiche: negli ultimi quindici anni si è scesi da un consumo di 110-120 litri l’anno a testa (parlo della Francia) di cosiddetto “vino da tavola” a 90-95 litri e questa cifra tende ancora a calare, mentre aumenta la tendenza a bere vini di buona qualità”.
– Se mi permette vorrei tornare all’Italia che in questa battaglia mondiale del vino si è impegnata con tutte le sue forze: lei pensa, per limitare il nostro discorso a Italia e Francia, che sono i maggiori produttori mondiali, quindi portati naturalmente a consumare i propri vini, ignorando quelli del vicino, che i vini italiani possano avere un avvenire in Francia?
“Io penso che il vino è eclettismo e che bisogna, certo, conoscere il proprio, ma allo stesso tempo non ignorare quello del vicino. Come ho già detto, in Italia si fanno vini eccellenti ed esistono tutti gli elementi per fare sempre meglio. In ogni regione d’Italia si trovano vini degni del massimo interesse e non soltanto in quelle più note dal punto di vista enologico. Per esempio mi viene in mente un vino di Sardegna, il Cannonau, che è delizioso e che accomunerei a uno Châteauneuf du Pape. Ma ci sono molte false idee da eliminare, per esempio quella che riguarda l’invecchiamento dei rossi in grandi botti, che il più delle volte danneggiano la qualità del vino piuttosto che migliorarla. Al loro posto bisogna decidersi ad adottare piccole botti da 150-200 litri e poi, dopo una prima fase d’invecchiamento, la cui durata può essere variabile, passare il vino nelle bottiglie.
Certo, la bottiglia pone problemi di magazzinaggio perché occupa più spazio, ma tutto considerato il gioco vale la candela. Specialmente con i bianchi sono stati fatti progressi favolosi: oggi non ci sono più bianchi ossidati e sono il più delle volte vini moderni e molto ben fatti. Ma bisogna fare attenzione a non peccare nel senso inverso, cioè mettere il vino troppo giovane in bottiglia. Voglio citare a questo proposito il caso di un giovane produttore che, conquistato da questa nuova tecnica, nel settembre del 1980 si è precipitato a mettere in bottiglia il suo bianco dell’anno precedente, commettendo un grave errore, perché avrebbe dovuto aspettare due anni. Insomma, se ho un appunto da fare direi che prima si metteva il vino bianco in bottiglia troppo tardi, mentre adesso, a volte, lo si mette troppo presto. Ma si tratta, penso, soltanto di incidenti di percorso.
I vini rossi, al contrario, sono ancora fatti secondo tecniche troppo vecchie. Certi vini, eccellenti, perdono per esempio il fruttato, che è la loro più grande virtù, a causa della loro permanenza in vecchie botti. Ciò detto si fanno eccellenti vini rossi: penso per esempio a un Cabernet-Sauvignon bevuto recentemente del quale conservo un ricordo gradevolissimo. Dopo questa premessa dirò che non c’è ragione che certi vini ben fatti e adatti al palato francese non abbiano successo qui: il problema può esistere soltanto al livello dei prezzi e della commercializzazione”.
– Se dovesse dare un consiglio ai produttori italiani, quale sarebbe?
“Di continuare sulla strada che hanno intrapreso e cercare di migliorare sempre più le tecniche e la qualità. Ma a volte i miei consigli non sono ascoltati: tempo fa avevo per esempio suggerito a un’importante azienda piemontese che va per la maggiore, di fare una Barbera più chiara, più leggera, più gradevole al palato, togliendole quell’aspro che io trovo insopportabile, ma mi sono sentito rispondere che i piemontesi non avrebbero apprezzato.
Un’altra riserva la faccio sul Chianti e per la ragione seguente: perché ci si lamenta che questo vino è troppo chiaro, non ha corpo e tende spesso all’acidità, quando basterebbe farlo con delle uve rosse invece che bianche? A questa mia obiezione mi è stato risposto che esiste in proposito una regolamentazione alla quale bisogna attenersi. Ma allora perché non modificarla? Antinori ha dato il buon esempio aggirando l’ostacolo e producendo un eccellente vino, il Tignanello, fatto con uve rosse. Si tratta per me di un esempio da seguire. In questo modo si eviterebbe l’eccessiva acidità, che viene dall’uva bianca e la necessità di una macerazione termica molto spinta”.
– Per terminare il discorso Italia, pensa che da punto di vista tecnico esista una sufficiente preparazione per affrontare un mercato sempre più vasto e gusti più diversi?
“Per il momento forse sì, ma ho riserve sulla formazione degli enotecnici e sulla regolamentazione della loro professione. Per me si dovrebbe introdurre l’obbligo di una formazione universitaria e probabilmente questa esigenza deve essere avvertita anche in Italia, perché ho notato che il numero di allievi italiani è in costante aumento alla Scuola di enologia di Bordeaux”.
– Molti passaggi del suo libro, “Le Goût du Vin. Le grand livre de la dégustation”, che costituisce un po’ la somma della sua lunga carriera di enologo, hanno provocato in alcuni lettori reazioni scandalizzate. Lei afferma, ad esempio, demolendo così un rito quasi religioso, che la decantazione preliminare è assolutamente inutile e addirittura dannosa, perché fisicamente e chimicamente non succede niente nel liquido così trattato.
“Certamente, e direi addirittura che un’areazione prematura rischia di distruggere l’eleganza degli aromi che sono stati sublimati dagli anni passati in bottiglia. L’unica maniera intelligente di aprire una bottiglia è immediatamente prima di berla. Altra leggenda da sfatare: portare una bottiglia a una temperatura di 18° prima di consumarla. Si tratta di un vero e proprio sacrilegio: infatti, un grande vino è frutto di un delicato equilibrio tra le sue tre componenti base: alcol, acidità e tannino. Al di là di un certo limite, l’alcol domina e brucia, ciò che provoca la predominanza di un gusto rozzo, su quello, più delicato, del tannino e così è l’acidità che ha la supremazia. Altro errore: riempire i bicchieri prima dei piatti. È infatti evidente che se i convitati mangiano prima di assaggiare i vini, si trovano nelle migliori disposizioni per giudicarli”.
Annate e vini del cuore
Come tutti i veri esperti, Émile Peynaud è un bevitore parco e accorto che confessa di non avere mai comprato una bottiglia in vita sua. Quali sono i suoi vini preferiti? I grandi Bordeaux tra gli altri, ma non gli unici. “Amo i vini che hanno un accento diverso dal mio”, dice. E le annate? Per lui quella del secolo è il 1961, “opera allo stesso tempo di un clima eccezionale e di una tecnologia moderna” e “bisogna dimenticare i 1975 per dieci-quindici anni”. Quanto poi alle annate tradizionalmente considerate eccezionali che mandano in estasi i cosiddetti conoscitori, in particolare 1928-1929-1945, Peynaud afferma con una franchezza disarmante che non lo hanno mai pienamente soddisfatto, cosa che ha provocato un’esplosione d’indignazione in certi “santuari”, ma reazioni del genere non fanno né caldo né freddo a questo grande maestro del vino che, indifferente alle mondanità e allo snobismo che spesso dominano in questo ambiente, si cura soltanto di dire la sua verità, e, dopo aver “curato”, da trent’anni a questa parte, i più grandi Bordeaux non si vergogna di confessare la sua incapacità di riconoscere un Baulliac da un Saint-Julien o un Margaux da un Sant-Estèphe.
“In questo esercizio” dice ridendo “ho conosciuto istanti di gloria, ma anche la vergogna fino alla feccia. E non me ne pento, perché la degustazione è una delle migliori scuole di modestia che esistano”.
Mino Colao