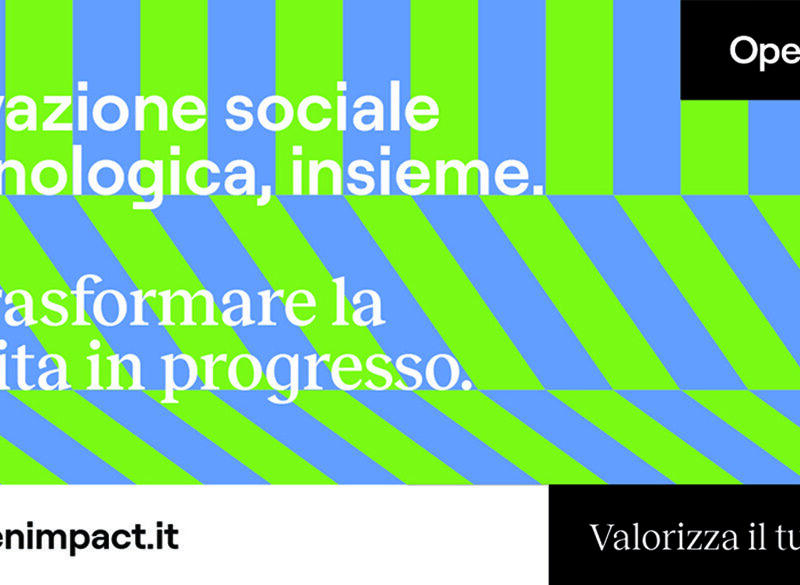Di Stefano Tesi
Fino a mezzo secolo fa nel Chianti, in Toscana e in gran parte d’Italia le botti per i vini rossi si fabbricavano con l’unica essenza all’epoca disponibile con abbondanza e, tanto enologicamente quanto meccanicamente, idonea alla bisogna: il castagno. In questo tipo di legno sono nati alcuni dei capolavori enoici nazionali. Nella stragrande maggioranza dei casi, si trattava di castagno locale.L'abbandono delle botti di castagno
Poi il progresso tecnico, la ricerca, le tendenze enologiche, l’industria, il marketing e le diffuse convinzioni negative che ne sono derivate hanno fatto il loro corso e il glorioso castagno è progressivamente regredito prima al rango di essenza inadatta al vino, poi a quella di materiale da pali o da ardere e infine a quella di risorsa forestale improduttiva, con fatale abbandono dei castagneti.Pro.va.ci, il progetto
È proprio da un progetto di recupero e di rilancio dei boschi toscani che la botte di castagno potrebbe però risorgere. Non come alternativa assoluta all’imperante rovere, bensì come legno “di nicchia” o come opportunità parallela, in un’ottica di diversificazione che andrebbe a contemperare tanto le esigenze del mercato, quanto quelle della comunicazione vinicola e della boccheggiante economia forestale.Primi risultati incoraggianti
Da qui l’idea, rilanciata in occasione di un recente convegno all’Accademia dei Georgofili, di includere, tra i possibili riusi per la valorizzazione della filiera del legno, l’utilizzo di botti di castagno locale come contenitori per alcuni vini prodotti nell’area del Chianti Classico. Sebbene sia ancora prematuro trarre conclusioni tali da orientare la produzione vinicola corrente, i primi risultati si sono rivelati interessanti e tali da far supporre che la via per un ritorno all’utilizzo delle botti di castagno non sia preclusa.La filiera
Il progetto si chiama, non a caso, “Pro.va.ci”, cioè PROgetto di VAlorizzazione della produzione legnosa dei boschi del Chianti, ed è stato sviluppato dalla Fondazione per il clima e la sostenibilità con il contributo dell’Ente Cassa di risparmio di Firenze, con il coordinamento di Raffaello Giannini, direttore scientifico della fondazione. I risultati sono stati esposti nel volume Il Vino nel Legno, edito dalla Firenze University Press. «Lo studio ha come obiettivo», spiega Marco Mancini, direttore della Fcs, «quello di individuare, nell’ambito del territorio del Chianti Classico, le strategie per associare una gestione sostenibile degli ecosistemi forestali con la valorizzazione dei prodotti della filiera foresta-legno.Dove il bosco e la vite sono in simbiosi
Particolare attenzione è stata dedicata al recupero degli usi del passato attraverso la realizzazione di vasi vinari realizzati con l’idea di “produrre il vino della casa con i carati prodotti con il legno dei boschi di casa”». La scelta del territorio del Chianti Classico è stata determinata dal fatto che in tale area, più che altrove, la presenza del bosco (circa 50.000 ettari su 97.500 di superficie totale, pari al 44%) si associa e si compenetra alla coltura della vite.La sperimentazione con il Sangiovese
«Un’indagine genetico-molecolare svolta su vecchie doghe recuperate nelle principali cantine dell’area e sui boschi di castagno e roverella autoctoni», continua Mancini, «ha consentito di stabilire che in passato le botti erano sempre realizzate con legno locale». Tra gli studi più significativi ci sono quelli sulla disponibilità potenziale del materiale legnoso dedicabile alla produzione di botti da vino: si stima che i boschi del Chianti Classico siano in grado di fornire, nell’arco di un ciclo produttivo, circa 2 milioni di tonnellate di castagno e roverella, corrispondente a circa 100.000 tonnellate annue.Questo articolo è tratto da Civiltà del bere 03/2016. Per continuare a leggere acquista l’ultimo numero nel nostro store (anche in edizione digitale) o scrivi a store@civiltadelbere.com. Buona lettura!