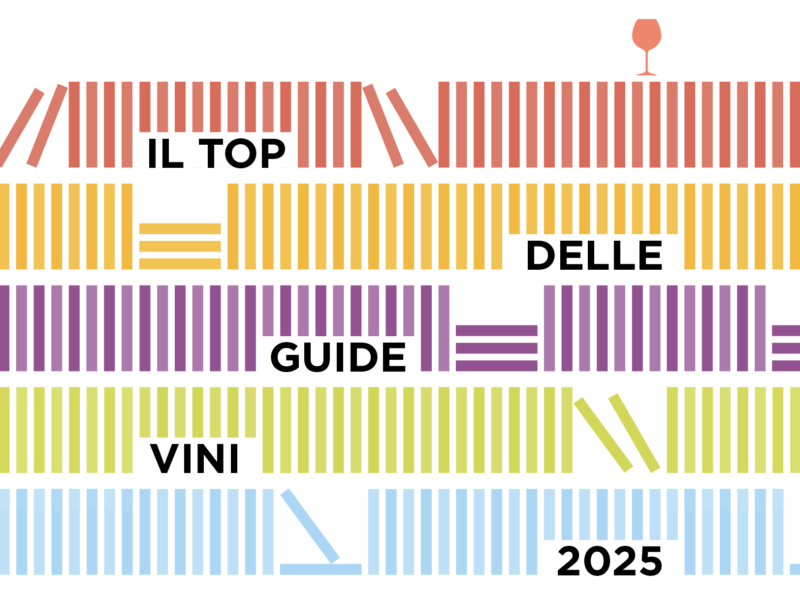Nove annate, dalla 2005 alla 2022, delineano il percorso che il rinomato Supertuscan del Chianti Classico ha compiuto nell’ultimo ventennio. Le novità in vigna e cantina introdotte dalla proprietà del gruppo Epi: dal superconsulente Pedro Parra all’uso di botti grandi.
Una verticale di Cepparello per scoprire l’evoluzione del gioiello di Isole e Olena, tra i Supertuscan da sole uve Sangiovese antesignani del Chianti Classico. Una verticale dal 2005 al 2021, più la 2022 in anteprima, per comprendere anche il futuro di questo grande vino. Soprattutto dopo che la Cantina di San Donato in Poggio (Firenze), sul versante occidentale della denominazione, nel 2022 è stata acquisita gruppo Epi di Christopher Descours, che possiede anche Biondi-Santi a Montalcino. Il range di annate presentate al ristorante Autem di Milano il 19 marzo può sembrare limitato nel tempo, dato che il Cepparello ha visto la luce nel 1980. «Purtroppo non possediamo un archivio così ricco che ci permetta di risalire oltre a una ventina di anni fa», ammette Emanuele Reolon, estate director di Isole e Olena, che ha ricevuto il testimone direttamente da Paolo De Marchi, che per quasi mezzo secolo è stato artefice del successo di questa azienda.
Il lavoro di parcellizzazione
L’excursus in nove annate ci ha permesso di comprendere bene il percorso del Cepparello nell’ultimo ventennio. Nato grazie alla convinzione che per produrre un grande vino non ci fosse bisogno di aggiungere vitigni internazionali alle uve Sangiovese, ma bastava usare le migliori (e propagare le piante da cui provenivano per rendere il vigneto sempre più qualitativo), oggi il Cepparello guarda sempre più lontano. «Dal 2024 stiamo lavorando con Pedro Parra (pedologo cileno consulente di fama internazionale, nda)», spiega Reolon, «per approfondire la conoscenza dei nostri vigneti e studiare la loro parcellizzazione, adattando così la viticoltura a ciò che c’è nel suolo. La dimensione delle parcelle così si sta via via rimpicciolendo».
Preservare il territorio e affrontare il cambiamento climatico
L’azienda sta portando avanti anche un progetto di reimpianto dei vigneti, in misura di 2 ettari all’anno, rifacendo i terrazzamenti che preservano il territorio del Chianti Classico e sostituendo impianti che prima erano a rittochino. Si ricercano cloni a maturazione tardiva con acidità naturale elevata: «Con i cambiamenti climatici in atto, questa caratteristica è diventata fondamentale. Ci permette di mantenere freschezza ed eleganza anche nelle annate più calde. Oggi abbiamo 12 cloni di Sangiovese selezionati dalla nostra azienda, sui 128 registrati e utilizzati nel mondo».
Nuove scelte in cantina
In cantina si aggiustano i protocolli: «Lavoriamo con acini integri, non pigiati», continua Reolon, «non eseguiamo follature e solo pochi rimontaggi. Dal 2021, accanto alle barrique abbiamo introdotto tonneaux e botti grandi con doghe più grandi. Prima al 5%, ma dalla scorsa vendemmia metà è legno grande, con la percentuale di legno piccolo destinata a scendere nei prossimi anni. In questo modo, abbiamo osservato che il Sangiovese affina meglio e nel calice si rivela più fine, elegante e longevo. L’evoluzione del vino è più lenta e favorisce le caratteristiche che vogliamo preservare. Inoltre stiamo costruendo una nuova area di vinificazione». Il focus della nuova proprietà rimane quello della valorizzazione del territorio, ma attraverso la produzione di un vino che sia sempre più identitario, emblematico e unico.

Come nasce il Cepparello
Da sempre prodotto in 50.000 bottiglie, Cepparello Igt Toscana nasce da sole uve Sangiovese selezionate dai 41 ettari dedicati a quest’uva (pari a circa il 25% del Sangiovese dell’intera tenuta) distribuiti tra i borghi di Isole, caratterizzato suoli ricchi di argilla e alberese, e Olena, dominato da galestro e calcare. «La variabilità dei terreni ci permette di scegliere i vigneti che si esprimono meglio in ogni annata», dice Reolon. «Per questo il Cepparello non sarà mai un single vineyard, ma una sinfonia di parcelle che cambia ogni anno». La selezione inizia già a fine luglio, con un primo screening delle parcelle candidate. Poi, durante la vendemmia, si opera un’ulteriore scrematura, seguita da una terza selezione dopo la fermentazione e una quarta, dopo un anno di legno. Alla fine, solo una trentina di parcelle entrano nel blend finale, che matura altri 6 mesi in legno e un anno in bottiglia.
La verticale
La 2005 è stata un’annata altalenante, che ha donato un vino più austero, seppur integro, contraddistinto da un frutto maturo e note di sottobosco. Strutturato ma ampio, di buona acidità e lungo finale il campione del 2010, nato da una vendemmia tardiva, contraddistinta da un’ottima maturazione del frutto. Considerata un’annata minore, la 2014 invece si distingue per equilibrio, succosità e freschezza, ancora tagliente. Meno espressivo e sfaccettato il 2015, con tannino un po’ ruvido. Il 2016, nato da una vendemmia equilibrata, dà buona prova di sé nonostante qualche nota più evoluta. Dal 2019 in poi si avvertono maggior aderenza e fedeltà all’annata. La generosa (in quantità e qualità) 2019 ha dato un vino opulento, fruttato e polposo; la mite e secca 2020 un campione di eleganza e finezza con tannino cesellato; la fresca 2021 un bouquet ampio e balsamico, e un sorso con struttura di filigrana e un bel finale iodato. Nella calda 2022, grazie alla selezione dai vigneti più freschi e sassosi di Olena, la beva si è mantenuta elegante e fresca. Quest’ultima annata è stata degustata in anteprima durante il pranzo.