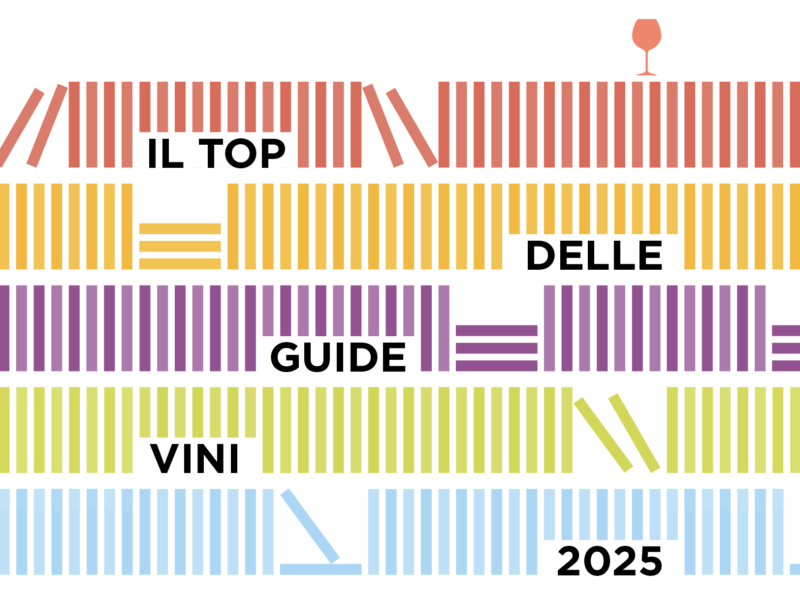Un lavoro corale, promosso dall’agenzia Laore con la collaborazione dell’Università di Sassari, per geocensire e valorizzare gli appezzamenti presenti sull’isola. Sullo sfondo c’è il progetto di candidatura Unesco.
La Sardegna ha un’anima antica, profonda, per certi aspetti inafferrabile. Così sono i suoi vini: testimoni emblematici delle stratificazioni culturali dell’isola, del suo carattere inconfondibilmente mediterraneo che dona al calice una sapidità vibrante e una balsamicità avvolgente. La produzione sarda vanta diversi primati, tra cui quello della viticoltura a piede franco, espressione con cui si indicano le piante che hanno radici proprie e non sono state innestate su quelle di vite americana; una pratica obbligatoria in tutta Europa a partire dalla metà dell’Ottocento per sconfiggere la piaga della fillossera.
Il patrimonio di vigne a piede franco
In Sardegna, su una superficie vitata che si aggira intorno ai 26 mila ettari (circa un 4% del totale nazionale), si stimano più di 430 ettari allevati a “franco di piede“. Si tratta di un patrimonio straordinario, non solo dal punto di vista vitivinicolo, ma anche paesaggistico e culturale, che l’amministrazione regionale si sta impegnando a salvaguardare e valorizzare, come è stato evidenziato durante un convegno organizzato dall’agenzia Laore Sardegna all’ultima edizione di Vinitaly. Tante le personalità al tavolo dei relatori, tra cui l’assessore all’agricoltura Regione Sardegna Gian Franco Satta, il presidente dell’Accademia italiana della Vite e del Vino Rosario Di Lorenzo (moderatore dell’incontro), il presidente di Assoenologi Sardegna Mariano Murru, il professore dell’Università di Sassari Luca Mercenaro e il presidente onorario dell’Oiv Mario Fregoni.

Siamo nel campo della viticoltura eroica
Nella sua relazione “I territori della viticoltura a piede franco” il professor Mercenaro ha ricordato i caratteri della produzione sarda, con oltre 2 mila ettari (circa l’8,5% del totale) classificabili da “viticoltura eroica” secondo i parametri del Cervim: appezzamenti sopra i 500 metri di altitudine e una pendenza superiore al 30%. «Sono localizzati soprattutto nei comprensori viticoli del Mandrolisai, del Nuorese (Barbagia) e in Ogliastra. A questi si devono aggiungere oltre 430 ettari ubicati nelle due isole minori Sant’Antioco e San Pietro e i litorali di Badesi e del Basso Sulcis con vigneti allevati a franco di piede».
Gli studi e il percorso di geocensimento
Per far conoscere e valorizzare la viticoltura eroica dell’isola e in particolare quella di montagna e delle isole minori, a partire dal 2019 l’agenzia Laore Sardegna ha avviato un’attività di studio e ricerca in collaborazione con il dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari. «Abbiamo attivato un percorso virtuoso di geocensimento dei vigneti. Vogliamo sviluppare un database che ci permetterà di assicurare un sistema di tracciabilità delle produzioni, elemento fondamentale per garantire l’origine del prodotto e una comunicazione trasparente per il consumatore», ha precisato il professor Mercenaro.
Sull’Isola di Sant’Antiaco la maggiore concentrazione
Ad oggi i vecchi dati disponibili parlano di 330 ettari a piede franco sull’Isola di Sant’Antioco, 130 ettari nelle aree litoranee di Badesi, tra i 20 e gli 80 nelle coste del Basso Sulcis, tra i 10 e i 30 nell’Oristanese a cui si aggiungono altri 25 ettari sparsi sul resto della Sardegna. «Si tratta di vigneti di piccole dimensioni, con viti anche centenarie allevate ad alberello classico, a volte appoggiati su semplici spalliere. I suoli sono tendenzialmente sabbiosi, con una bassa percentuale di argilla: in queste condizioni il parassita non riesce a riprodursi e quindi ad aggredire la pianta». Anche i terreni di matrice vulcanica e quelli a alta quota si rivelano favorevoli, come testimoniano i vigneti ancora oggi presenti in Campania, Valle d’Aosta e lungo le pendici dell’Etna.
Vini dalle speciali caratteristiche nutraceutiche
Il professor Fregoni ha sottolineato come il discorso sui vitigni a piede franco riguardi tutti gli Stati produttori, a cominciare dall’emisfero settentrionale, ma anche le zone equatoriali e del sud, si pensi ad esempio al Cile. «La viticoltura a piede franco non è una storia “finita”, al contrario. E oggi i vignaioli non devono temere di piantare a franco di piede, se le condizioni pedoclimatiche lo consentono. Bisogna ovviamente effettuare uno studio mirato dei suoli e poi decidere se si può procedere». I vini da piante a piede franco evidenziano una speciale finezza, una grande armonia gusto-olfattivo, anche perché nella maggior parte nascono da viti molto vecchie, vere e proprie reliquie che in alcuni casi superano i cento anni. «Sono vini dalle caratteristiche nutraceutiche superiori, che la vite innestata non può garantire. Penso in particolare alla loro ricchezza di polifenoli, tannini e antociani», ha concluso il professor Fregoni.
Verso la candidatura Unesco
Il presidente di Assoenologi Sardegna Mariano Murru ha ricordato il progetto internazionale volto alla candidatura delle viti coltivate a piede franco a Patrimonio dell’Umanità Unesco. Le linee guida del percorso sono state tracciate in un incontro a Napoli lo scorso gennaio. Un primo confronto tra produttori, ricercatori, enologi e sommelier provenienti da diversi Paesi tra cui Francia, Spagna, Svizzera, Grecia, Turchia, Argentina e territori italiani quali Sardegna, Val d’Aosta, Trentino, Lazio, Basilicata, Campania. Un convegno organizzato dal Comitato italiano per la tutela del piede franco presieduto da Silvano Ceolin e coordinato dalla vicepresidente Adele Munaretto, in collaborazione con l’associazione francese Francs de Pied.
Il commento del presidente Mariano Murru
«Il riconoscimento Unesco è un impegno ambizioso, che porterebbe grandi benefici sia ai produttori che alle comunità locali, contribuendo alla valorizzazione dell’ambiente de del paesaggio», ha precisato Murru, che è anche delegato del Comitato nazionale per la tutela del piede franco. Tutto parte dalla «necessità di salvaguardare le vigne coltivate a piede franco e la loro biodiversità. La Regione, tramite Laore e l’Università di Sassari, sta portando avanti un importante censimento delle viti a piede franco. Una preziosa mappa dettagliata che man mano coinvolgerà l’intera isola confermandola tra le prime regioni in Italia ad aver svolto questo prezioso lavoro».
I tre migliori assaggi al Vinitay
Il convegno a Vinitaly si è concluso con un tasting di sei etichette di vini da vigne a piede franco sarde che hanno colpito per la loro spiccata intensità e la profondità gusto-olfattiva. Tra gli assaggi più emblematici ricordiamo Aria di Marì, spumante Metodo Classico Brut Vermentino di Gallura Docg della Cantina Li Seddi, prodotto su sabbie dunali in agro di Badesi. Sorso dinamico, mineralità e sapidità sferzante.
Tra i Cannonau di Sardegna Doc più convincenti, citiamo quello delle Tenute Perda Rubia, da viti con età media di circa 25 anni in Ogliastra. Un’interpretazione moderna, agile e fresca, dalla chiusa mentolata. Infine, in rappresentanza del Carignano del Sulcis Doc dall’Isola di Sant’Antioco abbiamo apprezzato la versione di Carpante, con un naso di frutta scura, tannini vellutati, dolcezza aggraziata e speziata.